Per la pronuncia del nome, il DiPI ha «ˈlir, -iar».Protagonista di King Lear (Re Lear), tragedia, rappresentata nel 1606, tra le maggiori di W. Shakespeare. Egoista e autoritario, abdica, nell'illusione di poter conservare il piacere e le prerogative della regalità senza le responsabilità e i doveri inerenti; ma l'ingratitudine delle due figlie beneficate che lo scacciano gli apre gli occhi alla realtà. La tempesta del suo animo, riflessa nella tempesta degli elementi, determina in lui uno sviluppo duplice e inverso: più la sua mente si ottenebra fino alla pazzia, più nel suo animo si fa luce. Dalla iniziale atmosfera di fiaba del re che divide il suo regno fra due delle sue figlie, misconoscendo la minore che è la sola buona, attraverso la statura titanica che il vegliardo reietto assume nella tempesta, si segue l'espiazione della pazzia e il crescere della luce interiore, finché, purificato e redento, egli riconosce la bontà e l'amore nella figlia già ripudiata (Cordelia). Egli nasce, infine, allo spirito nel momento in cui muore sul cadavere della figlia che è stata uccisa.
La storia di Lear si trova nella Historia Regum Britanniae di Goffredo di Monmouth (1137), nella Chronicle di Holinshed, nel racconto di J. Higgins in Mirrour for Magistrates, nella Faerie Queene di E. Spenser (l. II, canto 10, st. 27-32), e in una tragedia, The true chronicle history of king Leir and his three daughters (1605), cui più che ad altro probabilmente attinse Shakespeare.
Cerco sùbito sull'Historia, per vedere che forma è usata per il nome in latino. Il nostro monarca figura nel libro II. Ora, il mio latino è scarsino... cito da questa versione:
Mi pare che il nome sia trattato come un sostantivo della seconda declinazione, con nominativo Leir anziché un più "ovvio" (?) *Leirus; non so quanto regolarmente o irregolarmente (penso a levir leviri). Il che in italiano ci darebbe Lèiro (...o Leìro?).Brutus autem cognomento Viridescutum cum patre remansit, regnique gubernaculo potitus post patrem duodecim annis regnavit: lmic successit Leir ejus filius pacis atque aequitatis amator. [...] Vixit deinde Leir post sumptum regnum viginti quinque annis, sed regnum tepide in fine rexit. [...]
Cum id Aganippo nunciatum fuisset, amore virginis inflammatus, misit iterum ad Leirum regem, dicens se salis auri et argenti, aliarumque possessionum habere: quia tertiam partem Galliae possidebat, se vero tantummodo puellam captare, ut ex illa haeredes haberet. [...]
Nuncius illico reversus direxit Leirum regem ad aliam civitatem, absconditque eum ibi donec omnia quae Cordeilla jusserat perfecisset. [...]
Interea misit Aganippus legatos per universam Galliam ad colligendum ita ea omnem armatum militem ut auxilio suo regnum Britanniae Leiro socero reddere laboraret. [...]
Tuttavia, in un'altra versione leggiamo, incongruamente, Leirum nel primo uso all'accusativo ma Leirem nel secondo (penultima riga). Così anche in quest'altra versione (di fonte imprecisata, magari la stessa).
Cercando Leiro in italiano nei Libri di Google troviamo attestazioni in testi cinquecenteschi (1, 2).
Trovo un Leire ottocentesco per il dramma scespiriano.
Sempre per quest'ultimo, si trova anche Leare (Lèare?): 1, 2.
Curiose queste attestazioni seguenti, ma purtroppo da un libro con anteprima ristrettissima, per cui non si capisce di più:
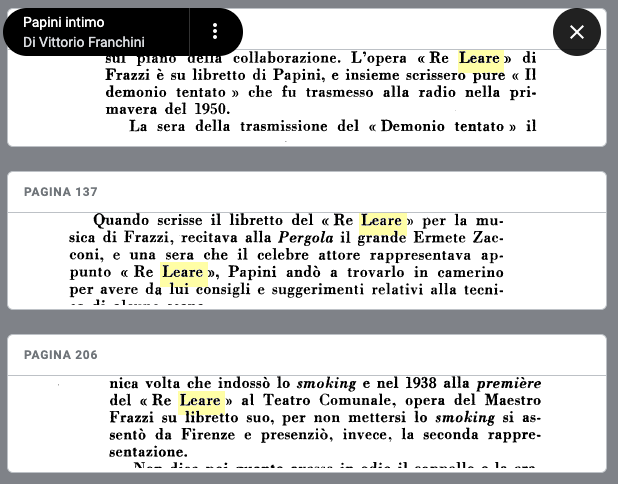
La stessa opera è invece citata come Re Lear qui.
Per tutte queste tre forme (Leiro, Leire, Leare), in ogni caso, le italianizzazioni paiono scarsissime, per cui nessuna sembra essere corroborata da un uso tradizionale, e si può scegliere in base ad altri parametri. Se quella di Goffredo di Monemuta è la prima menzione del personaggio, il nome latino, per quanto ne sappiamo, è l'«originale». Con questa poca roba, mi baserei su quello e andrei di Leiro.
Si possono naturalmente fare ricerche più approfondite, ma intanto apro il filone con questi primi elementi che ho raccolto.