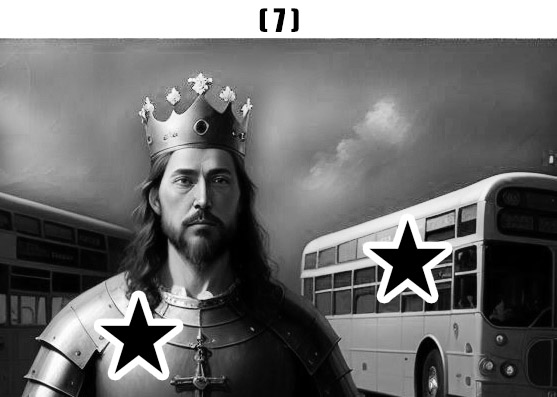G. M. ha scritto: dom, 14 apr 2024 22:21
Nei casi di
rebus e
quorum […] l'elemento usato è solo un pezzo di "significante", divenuto indipendente dal contesto originario, trasformato nel valore grammaticale (da ablativo plurale e genitivo plurale a "nominativo" singolare) e dotato di significati che, così da solo, nella lingua d'origine non ha.
Devo ammettere che è proprio cosí, tanto che, volendo coniare un neologismo latino per il gioco chiamato
rebus, questo non potrebbe essere che... *
rebus, -i, seconda declinazione. E in questo caso, sarebbe lecito italianizzarlo in *
rebo. Oppure, volendo giocare con il «fantalatino», si potrebbe perfino pensare a un nome della terza declinazione: *
rebus, -oris (sul modello di
tempus, -oris), italianizzabile anche come *
rèbore.

Ma questo è semplicemente un gioco; nella realtà, mi sembrerebbe ingiusto voler modificare questo termine per adattarlo. In proposito, mi piacerebbe aggiungere qualche informazione riguardo all'uso che se ne fa, in italiano e nelle altre lingue. Il significato principale di
rebus, com'è noto, è quello di «gioco enigmistico illustrato» (l'altro è quello figurato); ma si tratta di una definizione molto ampia: i
rebus hanno origine antica, e nelle diverse lingue hanno assunto forme e sottostanno a regole completamente diverse.
Fuori tema
Piú in dettaglio, quello che conosciamo noi, per averlo visto innumerevoli volte sulle riviste, è il
rebus [italiano] moderno (o contemporaneo), le cui caratteristiche sono state definite a metà dello scorso secolo, e che possono essere riassunte come:
- Omografia (contrapposta all'omofonia estera);
- Consequenzialità (il senso apparente dev'essere consistente, coerente e compiuto);
- Inequipollenza dei significati (ovvero non identità etimologica);
- Limite di 3 lettere per i grafemi.
Il primo vincolo, in particolare, caratterizza da sempre i
rebus italiani, che sono basati sulla grafia, mentre quelli inglesi o francesi si rifanno alla pronuncia (
eye=I,
cent=sans); il secondo, tipicamente italiano, impone una vignetta coerente e unica, e non disegni separati; il terzo (che impedisce l'identità etimologica fra gli elementi della vignetta e la soluzione) è anch'esso assente nei
rebus stranieri, il che dal nostro punto punto di vista ne fa un tipo di gioco sostanzialmente differente.
A chi volesse approfondire l'argomento, consiglio di leggere l'articolo della
Treccani, la
pagina guichipediana e, per altri dettagli tecnici, questa
guida pratica. Per la terminologia, c'è
quest'opuscolo 
Da ciò si deduce che la parola
rebus, in enigmistica, è una specie d'iperonimo: ne esistono di tanti tipi (
rebus stereoscopici, a domanda [e risposta], a rovescio, a cambio, e altri), tanto che è difficile trovare la parola in fondo all'enunciato (altro motivo per cui la sua terminazione consonantica non preoccupa piú di tanto). Per quanto detto, però, è pur vero che potrebbe aver senso distinguere il
rebus italiano dagli altri giochi omonimi conosciuti all'estero tramite un nome piú riconoscibile come «italiano», e questo nome (per rispettare il derivato
rebussista) potrebbe effettivamente essere
rebusse o
rebusso. Il problema sarà farlo accettare agli enigmisti!