Non sono molto convinto, non mi sembra così evidente. Tutti questi sono termini assai rari (uabaina e uasteco li scopro ora per la prima volta) e/o adattamenti di forestierismi relativamente recenti, comunque con marcata connotazione «esotica» (che potrebbe avere spinto al mantenimento d'una forma più straniera): più che forme italiane piene, potrebbero anche esseri considerati adattamenti incompleti, relativamente marginali, dove in tempi di maggior forza assimilatoria dell'italiano avremmo avuto più naturalmente, forse, vadi, guasteco, e simili...Infarinato ha scritto: ven, 31 mag 2024 14:46Ma non diciamo c…orbellerie! È possibilissimo, benché raro: uabaina, uadi, uasteco, Daua, Massaua etc.Lorenzo Federici ha scritto: gio, 30 mag 2024 21:05 Ciuaua non è proprio possibile secondo la fonotassi italiana, poiché /w/ può esistere soltanto prima di /ɔ/ o dopo /k/ e /g/.
Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
Moderatore: Cruscanti
Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
- Infarinato
- Amministratore
- Interventi: 5675
- Iscritto in data: gio, 04 nov 2004 10:40
- Info contatto:
Re: Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
Non c’entra nulla: qui si parla di fonotassi.  E comunque, a ritmo allegro, parole come capuano passano facilmente da [‑puˈaː‑] a [‑ˈpwaː‑]. Davvero vogliamo considerare tali sequenze come non genuinamente italiane?!!
E comunque, a ritmo allegro, parole come capuano passano facilmente da [‑puˈaː‑] a [‑ˈpwaː‑]. Davvero vogliamo considerare tali sequenze come non genuinamente italiane?!!
Qui a qualcuno, questa cosa dell’adattamento, ha dato veramente alla testa…
Qui a qualcuno, questa cosa dell’adattamento, ha dato veramente alla testa…
Re: Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
Non ho capito, può spiegarci meglio?
Non capisco bene, non mi sembra la stessa cosa: l'eventuale [w] «allegra» di capuano è fonetica; nei termini suddetti invece sarebbe una /w/ fonematica.Infarinato ha scritto: ven, 31 mag 2024 16:29 E comunque, a ritmo allegro, parole come capuano passano facilmente da [‑puˈaː‑] a [‑ˈpwaː‑]. Davvero vogliamo considerare tali sequenze come non genuinamente italiane?!!
Fuori tema
Infarinato ha scritto: ven, 31 mag 2024 16:29 Qui a qualcuno, questa cosa dell’adattamento, ha dato veramente alla testa…
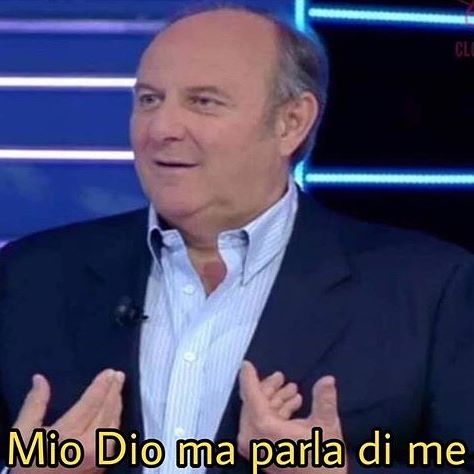
Non sia troppo severo... noi si è qui per imparare.
- Infarinato
- Amministratore
- Interventi: 5675
- Iscritto in data: gio, 04 nov 2004 10:40
- Info contatto:
Re: Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
Mi sembra di aver già fatto questo discorso almeno mille volte, ma, pazienza, rifacciamolo!
Come detto, c’è una differenza fra le restrizioni fonotattiche dell’italiano moderno e quelle che interessano gli esiti fiorentini di parole latine di tradizione ininterrotta. Sennò, ripeto: dovremmo rigettare imaginifico, accelero, clamoroso, blu e migliaia d’altre.
Inoltre, la fonotassi normalmente s’interessa della struttura sillabica (V, VC, CV, CVC, CCV, CCVC etc.) e della combinabilità di un fonema con quello immediatamente precedente o successivo. Ora, /wa/ in italiano esiste perché esiste (perlomeno) nei gruppi /kwa, ɡwa/: il fatto che —in parole di tradizione ininterrotta— la sequenza /wa/ non esista in altri gruppi (ma [wa] esiste anche in quelli a ritmo allegro… e sfido chiunque a pronunciare ottuagenario con [ua] anche a ritmo lento!) può essere considerato —sincronicamente parlando— una lacuna accidentale (anche se, diacronicamente, sappiamo che ha una sua giustificazione). Quindi, se sarebbe (
Credo di averlo già scritto, ma le uniche restrizioni fonotattiche che interessano /j/ e /w/ in italiano sono che la prima non può essere seguita da /i/ e la seconda non può essere seguita da /u/ (e che non sono mai geminate, ma questo non c’entra col nostro discorso).
Poi, certo, *ciguagua sarebbe «un po’ piú italiano» di *ciuaua, ma quest’ultimo non víola la fonotassi italiana. Del resto, se allarghiamo il campo delle combinazioni possibili, quanto italiana sarebbe davvero la sequenza ripetuta /ɡwa̍ɡwa/?
Re: «Chihuahua»
Uao!
- Lorenzo Federici
- Interventi: 981
- Iscritto in data: sab, 27 ago 2022 16:50
- Località: Frosinone
Re: Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
Personalmente, uabaina, uadi, uasteco, uistitì, Daua e Massaua li percepisco tutti come semiadattamenti o comunque termini da pronunciarsi con /u.a-/ o con artifici vari per mantenere la u. La pronuncia con /w/, nel mio caso specifico, mi riporta direttamente al mio dialetto. Mi sembra un po' la stessa situazione di termini ibridi come ayyubide /aju̍bide/ e in realtà anche newyorkese /njujorke̍se/. Lei li considererebbe del tutto italiani, soltanto perché terminano in vocale e suonano abbastanza italiani? Nulla vieterebbe di scrivere niuiorchese, ma la sequenza /Cju.jV/ non è chissà quanto comune, così come /gwa.gwa/, e allora tanto vale tenerci l'ibrido scritto almeno in parte secondo la grafia d'origine (magari scritta «new-yorkese»?). In realtà, questa stessa sequenza l'avremmo potuta avere anche se la città di Fiuggi non avesse, per assurdo, un nome italiano ben attestato e si fosse deciso quindi di usare quello locale come si fa per i comuni minori: Fiuio /fju̍jo/... quindi bisogna forse considerarla italiana?
Forse non c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato in un adattamento come niuiorchese, così come possiamo farci andare bene Massaua, ma lo vedo come uno stravolgimento della lingua che sì, esiste già in parte, ma è decisamente minoritario e risulta innecessario cercare di fare di più. È un po' come se domani decidessi di scrivere cassöla /kassœ̍la/ o anche Val di Süsa /val di sy̍sa/, o magari Locho Nesso /lɔ̍xo nɛ̍sso/ per Lochness. Non sarebbe impossibile, renderei l'idea e userei dei fonemi tecnicamente italiani, che però sono fonemi marginali. In quanto tali, cercherei di limitarne l'impiego alla pronuncia dei nomi stranieri e di adattare quelle poche eccezioni sul modello di altre parole o dell'origine della stessa, in base al singolo caso: Massava, vadi, guasteco eccetera.
/w/ si può pronunciare —circa, io lo dicevo comunque [vw] o [v] prima d'imparare a dirlo bene— ma eviterei di renderlo regolare. I termini con /w/ tra due vocali ci arrivano tutti da, scusate le parole forti, una certa ignoranza della lingua di fondo, la stessa che adatterà Churchill in Ciorcil piuttosto che in Cercillo o Ciorcillo. Dato che qua dentro, chi più (Infarinato, Carnby e gli altri utenti storici del foro) e chi meno (io e Giulio in prima linea, anche se lui è comunque decisamente più informato di me), abbiamo tutti una preparazione discreta in quanto a lingua italiana, forestierismi e simili, non mi pare il caso di scivolare su banalità del genere. Se un adattamento come civava, ciguava o anche ciguagua non piace (in particolare eviterei quelli con sillabe ripetute, mentre ciguava mi sembra un buon compromesso tra suono e somiglianza all'originale), che resti chihuahua.
Forse non c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato in un adattamento come niuiorchese, così come possiamo farci andare bene Massaua, ma lo vedo come uno stravolgimento della lingua che sì, esiste già in parte, ma è decisamente minoritario e risulta innecessario cercare di fare di più. È un po' come se domani decidessi di scrivere cassöla /kassœ̍la/ o anche Val di Süsa /val di sy̍sa/, o magari Locho Nesso /lɔ̍xo nɛ̍sso/ per Lochness. Non sarebbe impossibile, renderei l'idea e userei dei fonemi tecnicamente italiani, che però sono fonemi marginali. In quanto tali, cercherei di limitarne l'impiego alla pronuncia dei nomi stranieri e di adattare quelle poche eccezioni sul modello di altre parole o dell'origine della stessa, in base al singolo caso: Massava, vadi, guasteco eccetera.
/w/ si può pronunciare —circa, io lo dicevo comunque [vw] o [v] prima d'imparare a dirlo bene— ma eviterei di renderlo regolare. I termini con /w/ tra due vocali ci arrivano tutti da, scusate le parole forti, una certa ignoranza della lingua di fondo, la stessa che adatterà Churchill in Ciorcil piuttosto che in Cercillo o Ciorcillo. Dato che qua dentro, chi più (Infarinato, Carnby e gli altri utenti storici del foro) e chi meno (io e Giulio in prima linea, anche se lui è comunque decisamente più informato di me), abbiamo tutti una preparazione discreta in quanto a lingua italiana, forestierismi e simili, non mi pare il caso di scivolare su banalità del genere. Se un adattamento come civava, ciguava o anche ciguagua non piace (in particolare eviterei quelli con sillabe ripetute, mentre ciguava mi sembra un buon compromesso tra suono e somiglianza all'originale), che resti chihuahua.
- Infarinato
- Amministratore
- Interventi: 5675
- Iscritto in data: gio, 04 nov 2004 10:40
- Info contatto:
Re: Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
Lorenzo Federici ha scritto: ven, 31 mag 2024 23:08 Mi sembra un po' la stessa situazione di termini ibridi come ayyubide /aju̍bide/ e in realtà anche newyorkese /njujorke̍se/. Lei li considererebbe del tutto italiani, soltanto perché terminano in vocale e suonano abbastanza italiani?
- Sono fonotatticamente italiani;
- Non sono graficamente italiani;
- Non sono conformi alla fonotassi del fondo ereditario dell’italiano.
Re: Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
Sono confuso. Da quando ho iniziato a interessarmi più ampiamente delle strutture dell’italiano, e sono ormai non pochi anni, avevo creduto che l’uso di /w/ oltre /kw/ ⟨qu⟩, /ɡw/ e /wɔ/ (eventualmente /wo/) fosse un’estensione impropria, dovuta a scarse cura e consapevolezza della lingua (o a «paura» sociolinguistica dell'adattamento, per chi è consapevole e vorrebbe curare), non diversa da tante altre che osserviamo qui ma, almeno —diversamente da altre—, nell’uso (per ora?) minima e marginale, relegata ai casi come questi qui citati (scorrendo il DOP ne trovo altri*, e in maggioranza condividono gli stessi caratteri: notevole rarità o settorialità, data relativamente recente, connotazione «esotica» o comunque straniera marcata, spesso scarsezza dell’adattamento anche sotto altri aspetti a parte questo [es.: Kilauea, Ual-Ual, Uagadugu, Uarieu]; eventuali onomatopee e interiezioni), marcatamente riconoscibili —per me e credo anche altri— come linguisticamente stranieri o semistranieri non solo «accidentalmente» (pensiamo al fatto che, per i vocabolari, il [o un] plurale italiano «normale» di uadi sia uidian [Treccani, DOP 1 e 2]). In tante discussioni, negli anni, qui su Cruscate abbiamo ragionato di come adattare delle /w/ di questo tipo: oltre i Massaua e uadi citati, Halloween, Wikipedia, whisky, Washington, wicca, wok, ayahuasca, nahuatl… e nessuno, almeno per quel ch'io ricordi, ha mai sostenuto con particolare convinzione degli Allouino, Uichipedia, uischi, uicca, e simili. Dal che, anche, il mio stupore odierno. È chiaro che, vedendo ora dall’Infarinato una posizione così netta e convinta, c’è stato da parte mia, e forse d’altri, un fraintendimento a qualche livello. Rifletterò su quanto qui detto cercando di capirci qualcosa.
[*Vedo che per uiguro il DOP dà /wi-/; io lo pronunci[av?]o /ui-/ [ˌui̯-] (probabilmente influenzato anche dalla frequentazione d'altre lingue). Il DiPI, vedo, ha /ui-/ come seconda pronuncia.]
[*Vedo che per uiguro il DOP dà /wi-/; io lo pronunci[av?]o /ui-/ [ˌui̯-] (probabilmente influenzato anche dalla frequentazione d'altre lingue). Il DiPI, vedo, ha /ui-/ come seconda pronuncia.]
- Infarinato
- Amministratore
- Interventi: 5675
- Iscritto in data: gio, 04 nov 2004 10:40
- Info contatto:
Re: Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
Secondo me, ci stiamo perdendo in un bicchier d’acqua. 
Io contestavo semplicemente la frase di Lorenzo per cui «Ciuaua non [sarebbe] proprio possibile secondo la fonotassi italiana», il che è falso.
Con ciò non intendevo in alcun modo negare che eventuali varianti con /ɡwa/ non potessero essere «piú italiane», con ciò intendendosi «conformi alla fonotassi del fondo ereditario dell’italiano», che, però —ricordiamocelo sempre—, è mostruosamente restrittiva (coincidendo, per intendersi, col «primo sistema fonologico» di devotiana memoria).
Se non fossi stato di quest’idea, col nostro Marco non sosterrei Guichipedía (o, al massimo, lo scientifico Vicipedía) per Wikipedia, ma sia Guichipedía sia Vicipedía sia (il per me orrido ibrido) Vichipedía sia anche (il pigro anglicizzante) Uichipèdia (con /w‑/ e /‑dj‑/ o addirittura /‑di‑/) sono tutti fonotatticamente italiani.
Quando si propone un adattamento, non si può applicare meccanicamente una serie di regole per renderlo «il piú italiano possibile», ma bisogna di volta in volta valutare (competentemente e accuratamente) le «condizioni al contorno» (discorso, questo, che ho già fatto in merito all’adattamento di antroponimi e toponimi, dove le variabili di cui tener conto sono ancora di piú): etimo, distanza dalla grafia correntemente usata, esistenza di una già diffusa pronuncia italianizzata aderente alla nostra fonotassi (benché magari non a quella del fondo ereditario) etc. Tutto ciò, ovviamente, se vogliamo fare delle proposte concrete, e non fantalinguistica.
Concludo dicendo che non credo di essere nel torto affermando che il Castellani non si sarebbe mai sognato di adattare ulteriormente chihuahua, se non graficamente. Cerchiamo di non essere piú realisti del re, anzi, in questo caso, del Re.
Io contestavo semplicemente la frase di Lorenzo per cui «Ciuaua non [sarebbe] proprio possibile secondo la fonotassi italiana», il che è falso.
Con ciò non intendevo in alcun modo negare che eventuali varianti con /ɡwa/ non potessero essere «piú italiane», con ciò intendendosi «conformi alla fonotassi del fondo ereditario dell’italiano», che, però —ricordiamocelo sempre—, è mostruosamente restrittiva (coincidendo, per intendersi, col «primo sistema fonologico» di devotiana memoria).
Se non fossi stato di quest’idea, col nostro Marco non sosterrei Guichipedía (o, al massimo, lo scientifico Vicipedía) per Wikipedia, ma sia Guichipedía sia Vicipedía sia (il per me orrido ibrido) Vichipedía sia anche (il pigro anglicizzante) Uichipèdia (con /w‑/ e /‑dj‑/ o addirittura /‑di‑/) sono tutti fonotatticamente italiani.
Quando si propone un adattamento, non si può applicare meccanicamente una serie di regole per renderlo «il piú italiano possibile», ma bisogna di volta in volta valutare (competentemente e accuratamente) le «condizioni al contorno» (discorso, questo, che ho già fatto in merito all’adattamento di antroponimi e toponimi, dove le variabili di cui tener conto sono ancora di piú): etimo, distanza dalla grafia correntemente usata, esistenza di una già diffusa pronuncia italianizzata aderente alla nostra fonotassi (benché magari non a quella del fondo ereditario) etc. Tutto ciò, ovviamente, se vogliamo fare delle proposte concrete, e non fantalinguistica.
Concludo dicendo che non credo di essere nel torto affermando che il Castellani non si sarebbe mai sognato di adattare ulteriormente chihuahua, se non graficamente. Cerchiamo di non essere piú realisti del re, anzi, in questo caso, del Re.
Re: Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
Solo un’aggiunta su un dettaglio:
Vedo che il DiPI, oltre al mio uiguro, registra la pronuncia con /u/ oltre che con /w/ per vari di questi termini, segno che un certo uso —una certa difficoltà, come scrive Lorenzo?— del genere dev’essere (ancora?) diffuso: uadi, Uadai, Uollegà e Uolleggà, Uele e Uelle, wawa («uˈawa»)… persino per uè («uˈɛɛ»), wow («uˈa-»), oui («uˈi°, -*»). Per Ouija, addirittura, c'è solo la pronuncia con /u-/.Lorenzo Federici ha scritto: ven, 31 mag 2024 23:08 Personalmente, [...] li percepisco tutti come semiadattamenti o comunque termini da pronunciarsi con /u.a-/ [...]
- Infarinato
- Amministratore
- Interventi: 5675
- Iscritto in data: gio, 04 nov 2004 10:40
- Info contatto:
Re: Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
Perché, invece, le sequenze iniziali /u(ˈ)V/ sono italianissime (tradizionali)?G. M. ha scritto: sab, 01 giu 2024 13:40 Vedo che il DiPI, oltre al mio uiguro, registra la pronuncia con /u/ oltre che con /w/ per vari di questi termini, segno che un certo uso —una certa difficoltà, come scrive Lorenzo?— del genere dev’essere (ancora?) diffuso: uadi, Uadai, Uollegà e Uolleggà, Uele e Uelle, wawa («uˈawa»)… persino per uè («uˈɛɛ»), wow («uˈa-»), oui («uˈi°, -*»).
Piú che di «difficoltà», parlerei d’incertezza di fronte a sequenze iniziali tanto rare, e d’incertezza anche nella selezione dell’opportuno allomorfo dell’articolo [maschile]… Il che ci ricorda un fatto non irrilevante: sono i /w/ iniziali che realmente necessiterebbero d’essere mutati in /ɡw/ (non è quindi il caso di parole come chihuahua).
Re: Fonotassi dell’italiano e parole del fondo ereditario
No... anche per questo l'oscillazione in quella direzione mi pareva degna di nota circa il grado di spontaneità di /w-/.Infarinato ha scritto: sab, 01 giu 2024 17:14 Perché, invece, le sequenze iniziali /u(ˈ)V/ sono italianissime (tradizionali)?
Chi c’è in linea
Utenti presenti in questa sezione: Nessuno e 3 ospiti